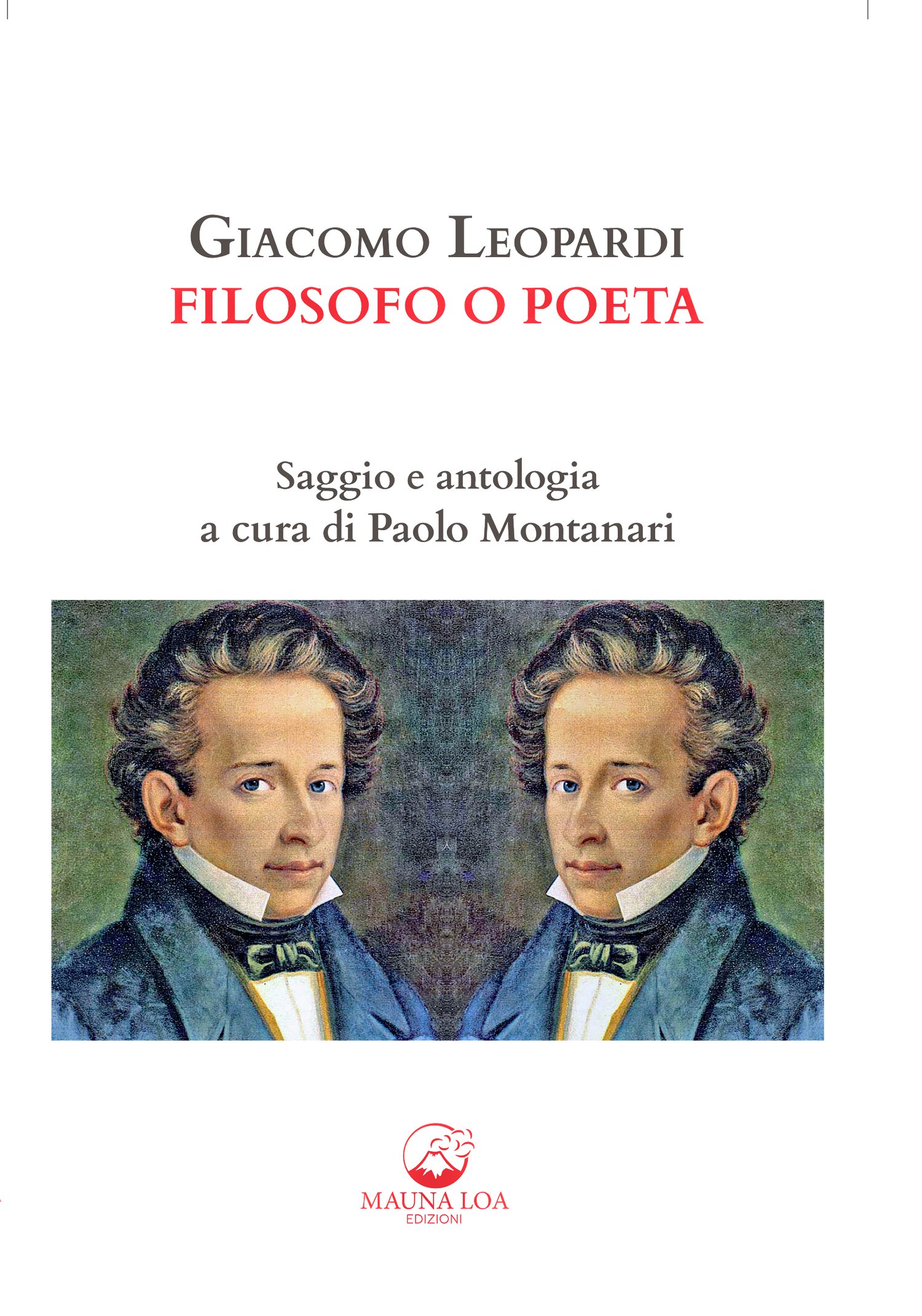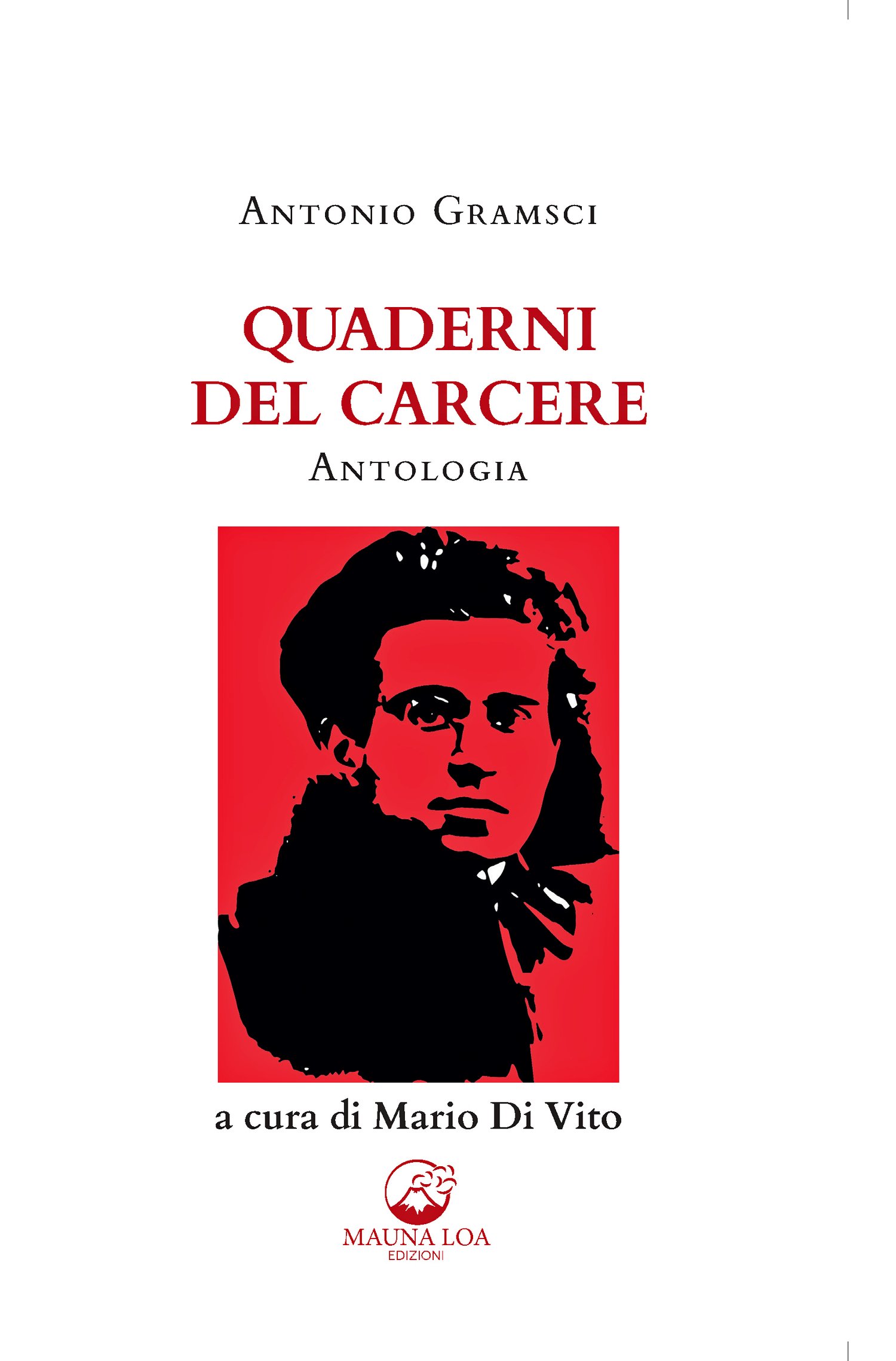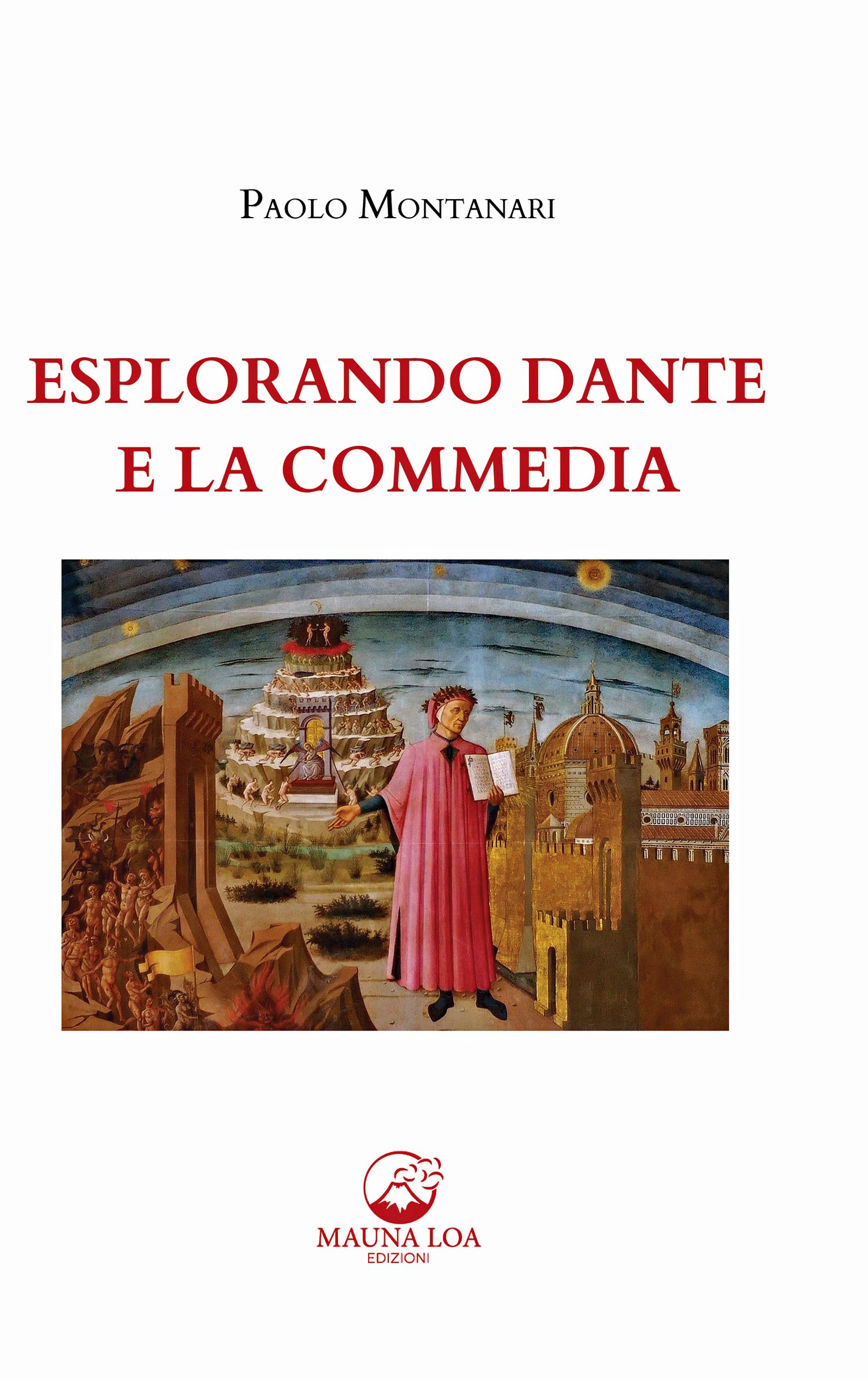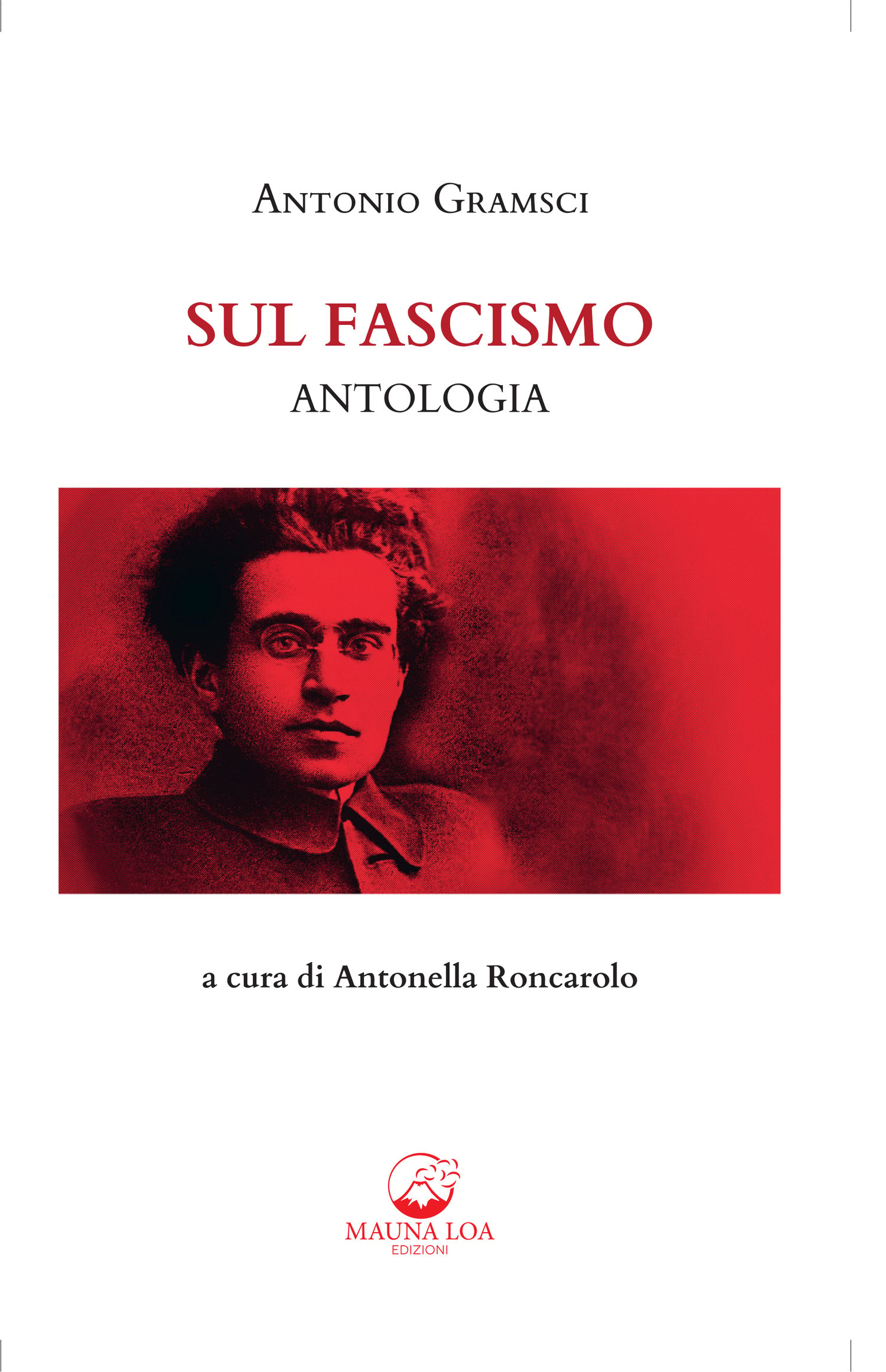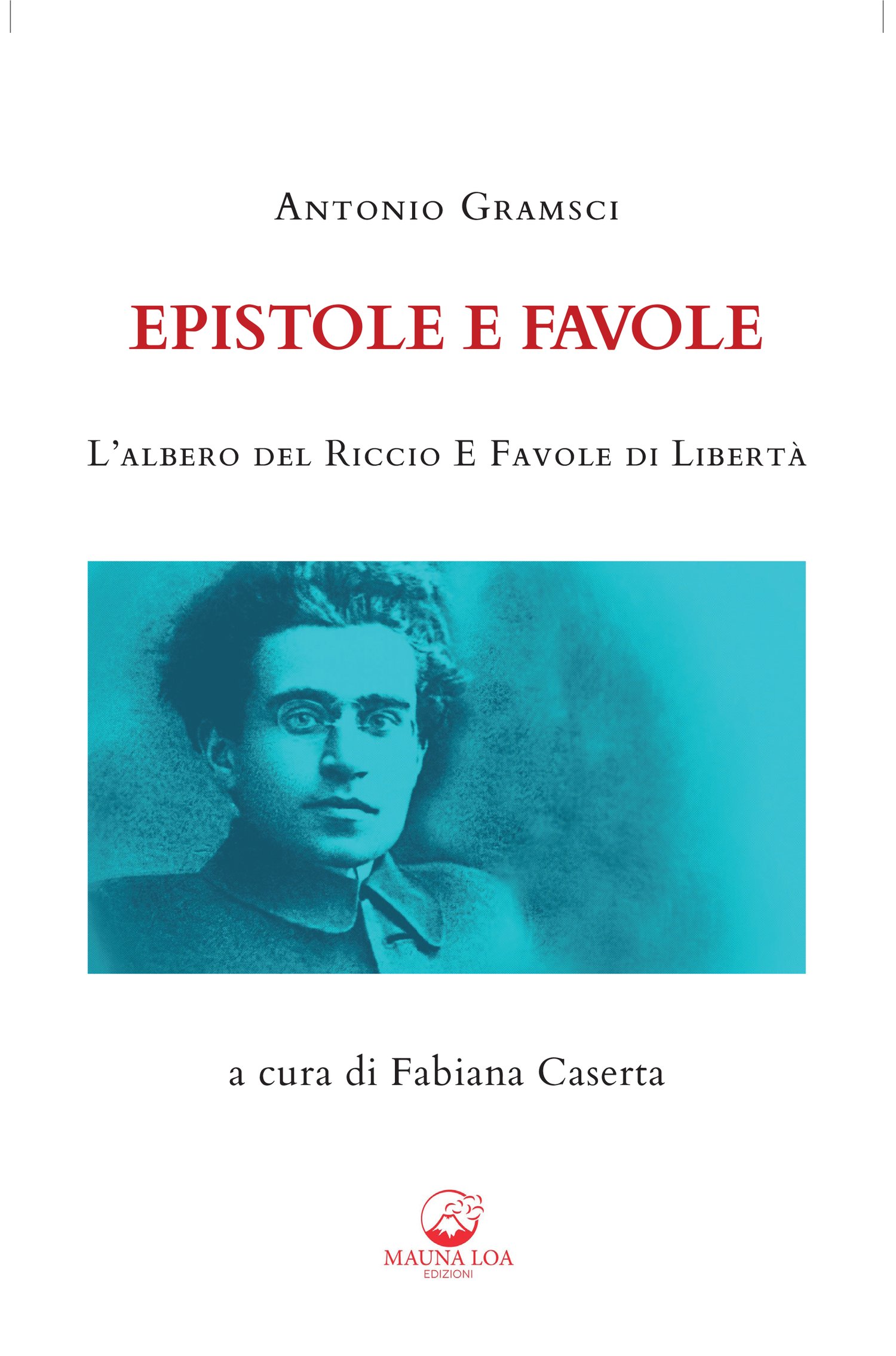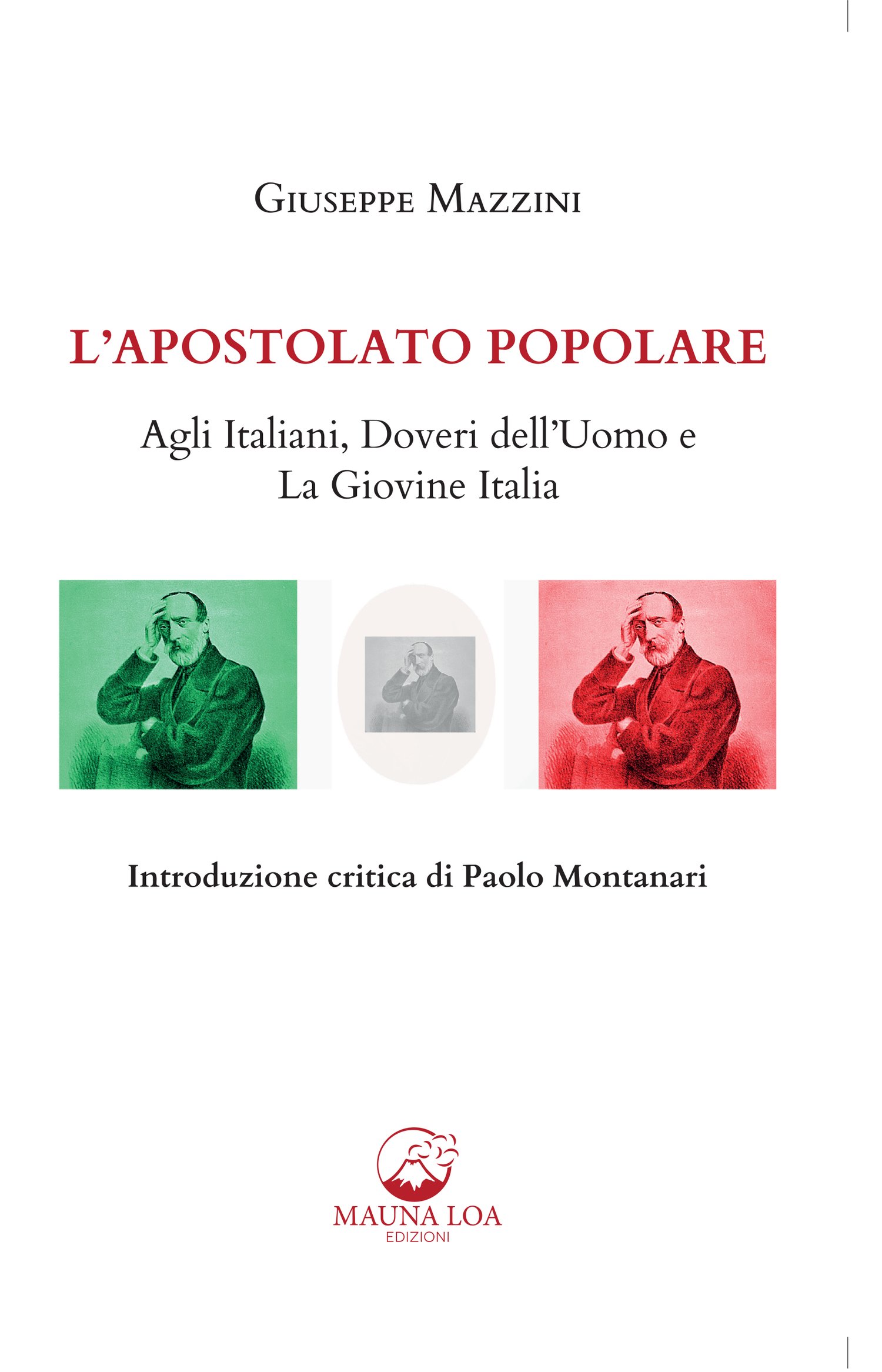
L’apostolato Popolare: Agli Italiani, Doveri dell’Uomo e La Giovine Italia di Giuseppe Mazzini
Autore: Giuseppe Mazzini
Introduzione critica: Paolo Montanari
Titolo: L’apostolato Popolare:
Agli Italiani, Doveri dell’Uomo e La Giovine Italia
Pagg edizione cartacea: 278
Lingua: italiano
Formato: Epub con Adobe DRM
Prezzo: 7,99 euro
Edizione: Mauna Loa, 2022
EAN/ISBN: 979-12-80456-21-2
IL TESTO: I fondamenti della Visione Mazziniana in tre dei massimi scritti di Giuseppe Mazzini: Agli Italiani, La Giovine Italia e Doveri dell’Uomo, accompagnati dalla introduzione critica di Paolo Montanari che si sofferma sul concetto di Europa e sulla questione femminile per Mazzini. Esponente di punta del patriottismo risorgimentale, Giuseppe Mazzini contribuì in maniera decisiva, con le sue idee e la sua azione politica, alla nascita dello Stato unitario italiano, mentre le sue teorie furono di grande importanza nella definizione dei moderni movimenti europei per l’affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato. Di lui scrisse Carducci: “Giuseppe Mazzini più che nessuno mai ebbe sublime, splendente, soleggiante la visione della terza Roma, non aristocratica, non imperiale, non pontificia, ma italiana”. E Klemens von Metternich lo ricordò così: “Ebbi a lottare con il più grande dei soldati, Napoleone. Giunsi a mettere d’accordo tra loro imperatori, re e papi. Nessuno mi dette maggiori fastidi di un brigante italiano: magro, pallido, cencioso, ma eloquente come la tempesta, ardente come un apostolo, astuto come un ladro, disinvolto come un commediante, infaticabile come un innamorato, il quale ha nome: Giuseppe Mazzini”.

L'AUTORE: Giuseppe Mazzini (Genova, 22 giugno 1805 – Pisa, 10 marzo 1972) è stato patriota, politico, filosofo e giornalista ed è considerato il padre del Risorgimento italiano. Poco dopo la laurea, entrò nella Carboneria, società segreta con finalità rivoluzionarie, e si dedicò al giornalismo per divulgare i suoi ideali e raccogliere adesioni al movimento carbonaro. Tradito e denunciato alla polizia, subì l’esilio; fondò nel 1831 a Marsiglia la Giovine Italia, associazione politica che aveva come obiettivo quello di riunire gli stati italiani in una sola repubblica e liberare il popolo italiano dagli invasori stranieri. In seguito fondò altri movimenti politici con lo scopo di liberare ed unificare altri stati europei: la Giovine Germania, la Giovine Polonia e la Giovine Europa. Per la sua attività rivoluzionaria, Mazzini fu condannato a morte due volte, di nuovo esiliato, e riparò a Londra per diversi anni. Riuscì a rientrare nella sua amata Italia, a Pisa, il 7 febbraio 1872, sotto il falso nome di Giorgio Brown; ivi morì dopo poco più di un mese.
IL CURATORE: Paolo Montanari è nato a Pesaro, dove vive e lavora. Giornalista pubblicista, è membro di varie giurie letterarie e da 25 anni è operatore culturale; in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pesaro organizza incontri culturali. Ha tenuto seminari presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione sul cinema, in particolare sui registi Rossellini e Olmi. A sua cura un importante convegno a Pesaro su Pier Paolo Pasolini. Dal 2019 a oggi tiene un ciclo di conferenze in varie città su Leonardo, Raffaello e Leopardi. Ha curato per la Mauna Kea Edizioni la edizione ad Alta Leggibilità di “Uno, Nessuno e Centomila” di Luigi Pirandello (2020); per la Mauna Loa Edizioni ha curato la antologia “Giacomo Leopardi: Filosofo o Poeta” (2020) e ha scritto il saggio “Esplorando Dante e la Commedia” (2021).
ESTRATTO: GRAMSCI E MAZZINI
Gramsci fu critico del pensiero mazziniano. Nel saggio di Vincenzo De Robertis, “A. Gramsci e L’Unità d’Italia” (Feltrinelli, 2010) al cap. V si analizza il pensiero critico di Gramsci partendo dalle sconfitte del biennio 1848-49 che spostarono a destra tutto l’asse politico del Paese. Le parole d’ordine dell’unificazione del territorio nazionale e dell’indipendenza dell’Austria diventarono oggettivamente prioritarie rispetto a quelle dell’assetto istituzionale del nuovo Stato (monarchia o repubblica). L’interpretazione risorgimentale impegnò Gramsci per molto tempo in particolare sul processo storico che, nel secolo XIX, produsse la travagliata costituzione dello stato italiano unitario. Per Gramsci questo processo fu diretto da forze moderate e il cosiddetto Partito d’azione (le correnti che si richiamavano in parte a Mazzini e Garibaldi) si rivelò incapace di svolgere un’opera trasformatrice nella realtà politica del suo tempo. Per Gramsci quella del Risorgimento fu una “rivoluzione mancata”, per la natura e la negazione di una causa sociale. Gramsci accusò il Par-tito d’azione di essere stato un partito di una élite borghese, incapace o indifferente nel cercare l’appoggio della sfera non borghese e popolare della società. Ma appoggio da quali ceti? Non certo quelli borghesi moderati difesi dal Gioberti e dai movimenti cattolici dell’Ottocento. A questo proposito è interessante il saggio di Enrico Landolfi “Gramsci e Gioberti nel discorso nazionale popolare” (Edizioni dell’Oleandro, 1999). Gramsci addirittura divenne insofferente ed eterodosso rispetto a Marx, in quanto nell’Ottocento non vi erano un proletariato e una classe operaia organizzata, il solo soggetto, secondo i principi marxisti, capace di promuovere una trasformazione radicale della società. Ma la rivoluzione mancata nel Risorgimento per Gramsci fu dovuta alla mancanza di coinvolgimento e consenso dei contadini. Una forza sociale che tutelava anche il folclore popolare, e che avrebbe dato un sostanziale contributo sociale e un adeguato impulso sociale innovatore. Un movimento democratico che si sarebbe realizzato se fosse stato capace di farsi un partito-giacobino: se avesse saputo fare propri gli interessi della classe contadina che, da vittima e sfruttata dai latifondisti, sarebbe potuta diventare di piccoli proprietari. Mazzini, pur essendo ideatore della Giovine Europa e, nel secondo periodo, anche della Giovine Francia, non tenne conto per niente del giacobinismo francese che, evitando l’isolamento delle città, aveva convertito le campagne alla rivoluzione. Ma la critica al processo risorgimentale per Gramsci non significò la sua negazione, perché, oltre all’Unità d’Italia, favorì la crescita della borghesia, gettando le basi dello sviluppo del capitalismo italiano. Un capitalismo dimezzato per Gramsci, che non poté usufruire di un adeguato mercato per i suoi prodotti, e legato all’arretra-tezza del meridione. Una occasione mancata anche da un punto di vista politico. Scrive Gramsci all’inizio dei Quaderni del carcere (10, II): “La maggior parte degli uomini sono filosofi in quanto operano praticamente e nel loro pratico operare è contenuta implicitamente una concezione del mondo, una filosofia”.
Il filosofo Diego Fusaro nel suo saggio “Antonio Gramsci e l’interpretazione del Risorgimento” rileva che “a giudizio di Gramsci tale rivoluzione potrà essere fatta solo attraverso un’alleanza tra proletariato settentrionale e contadini meridionali”. Ma la Storia ha dato altre risposte di allontanamenti e migrazioni.
Se oggi social ha acquistato un significato multimediale, di sociale non ha proprio nulla, non solo da un punto di vista marxista, ma anche come welfare e nella visione mazziniana. In Gramsci la scelta sociale si poteva realizzare, come dicevamo, in una alleanza tra operai e contadini. In Marx, economista su cui si è basato il comunismo scientifico, si poteva realizzare con la lotta del proletariato. Infatti, di sociale in maniera pragmatica parlavano quelli della Prima Internazionale dei Lavoratori, fondata nel 1864 e che vedeva uniti per la prima volta socialisti, anarchici e repubblicani. In questo caso almeno idealmente si trovavano uniti i seguaci di Marx, di Bakunin e di Mazzini. Luca Bagatin, nella rivista L’Opinione delle libertà, ha svolto una interessante riflessione su questo tema.